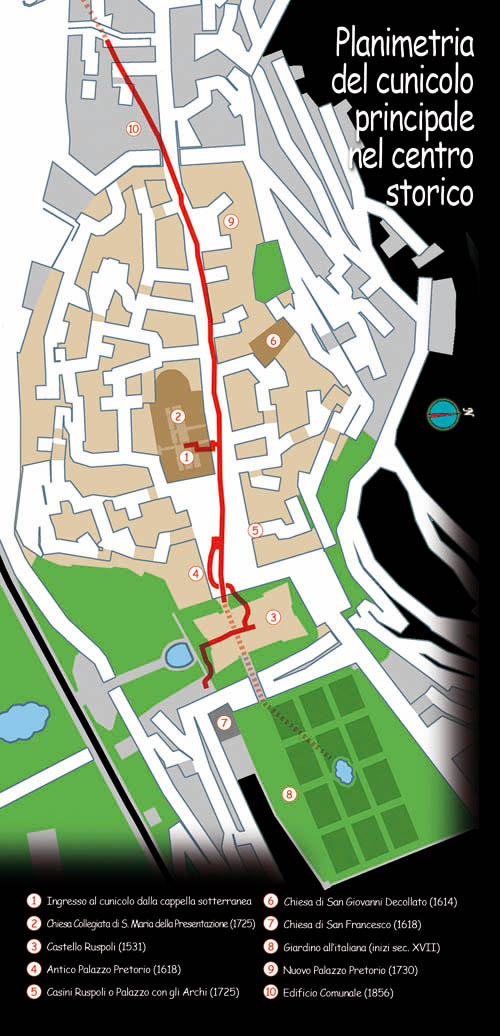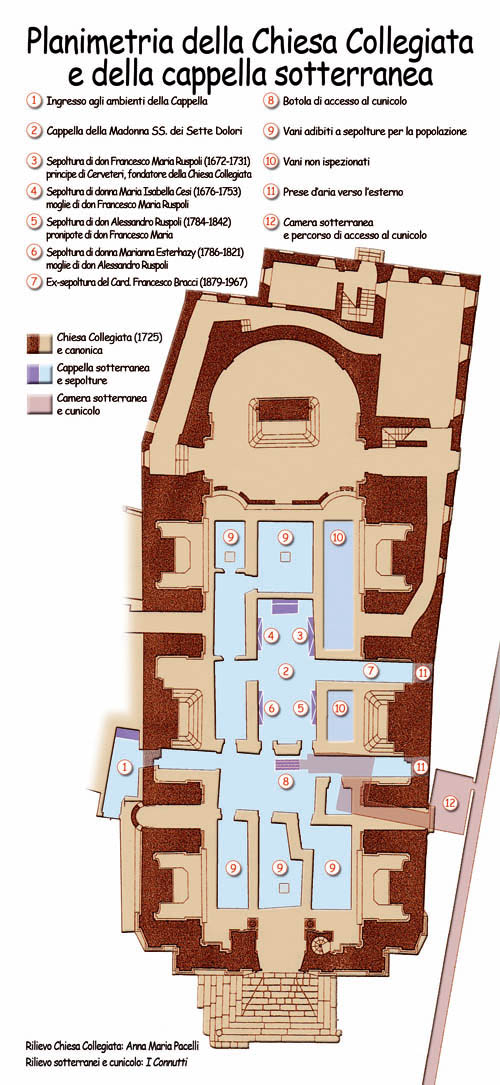|

31.05.11
Alla scoperta de... i connutti
di
Vincenzo Pacelli
(pubblicato
su Cronos - anno II, n.2 - aprile 2009)
Riveduto, corretto ed ampliato in più parti
 Cuniculus,
termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:
coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa
parola. Cuniculus,
termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:
coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa
parola.
Più o meno
con la medesima logica, i connutti,
vocabolo che nel dialetto vignanellese indica i condotti sotterranei, è
divenuto in questi ultimi anni, sinonimo paesano, un po’ scherzoso,
con cui vengono indicati i componenti dell’associazione omonima che si
propone di esplorare e valorizzare queste affascinanti realtà del
sottosuolo locale.
I cunicoli
nascono essenzialmente come strutture idrauliche di drenaggio o
trasporto dell’acqua messe in atto da numerose civiltà fin dai tempi
più remoti. Maestri nella realizzazione di condotte d’acqua,
sotterranee e non, furono i Romani, i quali appresero le tecniche  dagli
Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle
pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal
Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del
Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani. dagli
Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle
pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal
Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del
Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani.
Fra il VII
ed il III secolo a. C. a Vignanello è esistito un centro falisco di un
certo rilievo. Oggetto di studi nei primi anni del XX secolo, ha
restituito molti manufatti, tratti di mura, parte del basamento di un
tempio sul colle del Molesino ed una necropoli nella valle della Cupa.
Naturalmente
nel territorio vignanellese non mancano i cunicoli scavati nel tufo. Per
alcuni di essi è evidente l’origine falisca o romana, individuabile
in base alla loro localizzazione, alle tecniche di scavo, alle
dimensioni ed alla forma; altri sono di dubbia attribuzione, avendo subìto
nel corso del tempo riadattamenti ad opera di diverse mani,
altri ancora possono essere collocati in un’epoca decisamente più
recente.
 Fino a
qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come
unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi
arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di
spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro
storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso
non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono
attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti
fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di
partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli
interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con
alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,
camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni
scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate... Fino a
qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come
unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi
arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di
spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro
storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso
non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono
attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti
fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di
partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli
interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con
alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,
camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni
scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate...
 Come
non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati
simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce
ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha
preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...
fare un po’ di luce. Come
non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati
simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce
ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha
preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...
fare un po’ di luce.
Durante i
primi anni di attività sono state effettuate numerose ricognizioni,
tanto nel centro abitato di Vignanello, quanto nel territorio
circostante, seguendo le indicazioni di chi c’era già stato. Spesso
in  un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di
campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla
terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei
terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase
iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a
raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità
naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si
è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti
posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando
rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando
gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie. un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di
campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla
terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei
terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase
iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a
raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità
naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si
è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti
posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando
rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando
gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie.
 Punto
di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della
chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è
necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il
principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa
parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla
realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture
della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola
cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova
costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,
fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed
inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il
novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni
più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello
splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue
spoglie mortali. Punto
di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della
chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è
necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il
principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa
parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla
realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture
della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola
cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova
costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,
fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed
inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il
novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni
più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello
splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue
spoglie mortali.
 Il Signorino
(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il
feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha
il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte
a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da
quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di
quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821). Il Signorino
(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il
feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha
il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte
a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da
quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di
quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821).
Dietro alle
loro nobili sepolture si trovano gli ambienti nei quali venivano deposti
i defunti della popolazione, di solito avvolti in umili sudari, più di
rado in casse di legno. La pratica delle sepolture negli ossari
all’interno della chiesa è proseguita fino alla seconda metà
dell’800, applicando con più di 50 anni di ritardo le leggi
napoleoniche che fin da 1804 (Editto di Saint Cloud) imponevano per
norme igieniche la realizzazione dei cimiteri al di fuori dei centri
abitati.
Lo
documentano i registri degli atti di morte dell’archivio parrocchiale,
che insieme alle iscrizioni poste all’ingresso degli ossari (soltanto
due sono ancora leggibili) attestano anche la consuetudine di utilizzare
delle camere distinte per uomini, donne, ragazzi, neonati e religiosi.
Molti degli
ossari sono stati sgombrati diversi anni fa, mentre alcuni conservano
ancora il loro macabro contenuto, attualmente visibile dietro la
protezione di vetri appositamente collocati da I
Connutti.

 Ma per quale
motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle
attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una
botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente
scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli
obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che
attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi
planimetria). Ma per quale
motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle
attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una
botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente
scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli
obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che
attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi
planimetria).
Questo
condotto sotterraneo ospita ancora oggi i resti dell’acquedotto in
terracotta voluto agli inizi del ‘600 da Ottavia Orsini, feudataria di
Vignanello, per portare acqua al giardino all’italiana da lei
realizzato attiguo al castello, e per l’approvvigionamento della
popolazione.
 Al suo
interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma
non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via
degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti. Al suo
interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma
non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via
degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti.
Percorrendolo
si incontrano diversi pozzi dalla sezione perfettamente circolare, che
si elevano fino al livello del suolo, chiusi da una sorta di tavolato
(tutti tranne uno). Andando in direzione della Valle
(piazza Cesare Battisti), la loro altezza aum enta gradualmente, facendo
avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.
Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità
del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo
valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si
addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte. enta gradualmente, facendo
avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.
Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità
del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo
valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si
addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte.
Nel tratto
attualmente percorribile il cunicolo ha un’altezza che varia dai 200
ai
290 centimetri
circa, la larghezza non è mai inferiore a
80 centimetri
, arrivando in alcuni tratti anche ad un metro, mentre la sezione assume
diverse forme, da ogivale a squadrata e in alcuni punti le due sagome si
intersecano generando una sorta di sarcofago antropomorfo. Lungo le
pareti, ad intervalli più o meno regolari e ad  un’altezza compresa
fra 170 e
180 centimetri
, vi sono delle piccole nicchie scavate nel tufo il cui scopo non è
stato ancora del tutto chiarito. un’altezza compresa
fra 170 e
180 centimetri
, vi sono delle piccole nicchie scavate nel tufo il cui scopo non è
stato ancora del tutto chiarito.
Sotto al
piano di calpestio del cunicolo sono murate, in una massicciata alta
circa 50/60 centimetri, due tubature in terracotta, l’acquedotto di
Ottavia Orsini, che in passato sfruttando il principio dei vasi
comunicanti, portava l’acqua dalle sorgenti (poste nel colle di Talano
in direzione di Vallerano) fino al castello e al giardino, superando il
notevole dislivello dato dalla concavità della valle della Cupa.  Queste
tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove
il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo
all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca
rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la
preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha
avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle
condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta
in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte
dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano. Queste
tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove
il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo
all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca
rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la
preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha
avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle
condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta
in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte
dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Ma
non voglio raccontare oltre, mi fermo qui, non senza ricordare che
l’associazione I Connutti,
sempre supportata nelle sue attività da alcuni membri della locale
sezione del G.A.R. (Gruppo Archeologico Romano) ha partecipato gli anni
passati alle Giornate Europee del
Patrimonio organizzate dal F.A.I. (Fondo per l’ambiente Italiano)
in settembre, durante le quali sono state aperte alle visite sia la chiesa
collegiata che la cappella sotterranea ed
un tratto del cunicolo.

Attualmente
si sta procedendo con la pulizia di un altro tratto di cunicolo che
puntiamo a rendere al più presto visitabile e si continuano a studiare
i reperti ritrovati per poterli mostrare organicamente nelle teche
gentilmente messe a disposizione dall'amministrazione comunale poste
lungo il percorso delle visite nei locali della cappella sotterranea. Il
tutto, con opera di totale volontariato de I Connutti che
dal 2003 sono aumentati e continuano a portare avanti i loro obiettivi
con passione e dedizione.
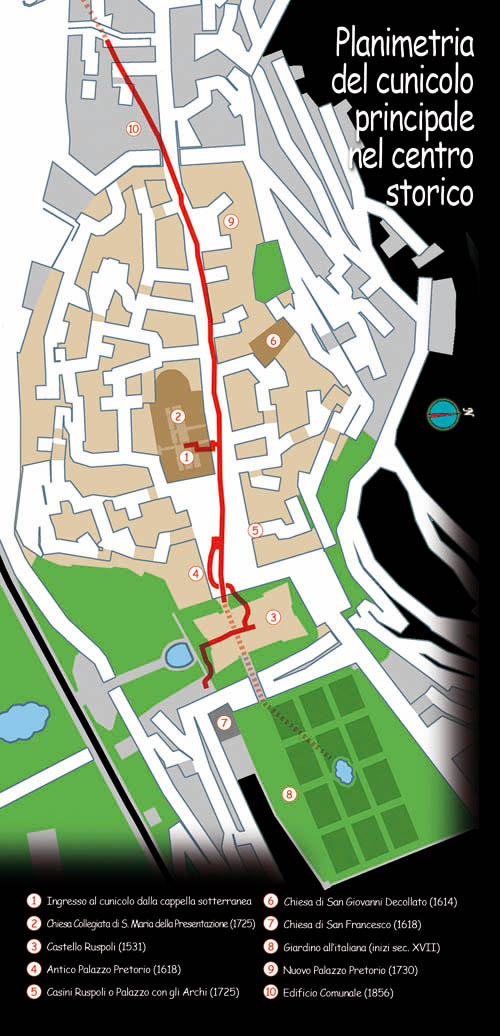
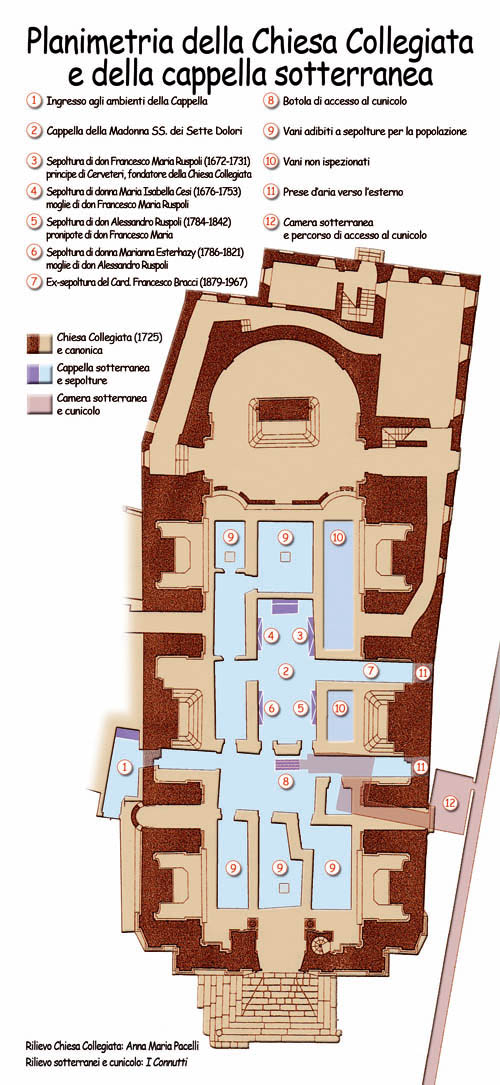
Alcuni
scatti dalle aperture alle visite...

.

.











|

 Cuniculus,
termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:
coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa
parola.
Cuniculus,
termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:
coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa
parola. dagli
Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle
pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal
Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del
Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani.
dagli
Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle
pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal
Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del
Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani. Fino a
qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come
unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi
arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di
spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro
storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso
non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono
attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti
fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di
partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli
interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con
alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,
camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni
scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate...
Fino a
qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come
unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi
arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di
spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro
storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso
non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono
attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti
fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di
partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli
interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con
alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,
camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni
scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate... Come
non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati
simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce
ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha
preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...
fare un po’ di luce.
Come
non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati
simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce
ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha
preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...
fare un po’ di luce. un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di
campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla
terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei
terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase
iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a
raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità
naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si
è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti
posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando
rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando
gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie.
un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di
campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla
terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei
terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase
iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a
raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità
naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si
è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti
posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando
rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando
gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie. Punto
di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della
chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è
necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il
principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa
parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla
realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture
della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola
cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova
costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,
fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed
inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il
novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni
più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello
splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue
spoglie mortali.
Punto
di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della
chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è
necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il
principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa
parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla
realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture
della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola
cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova
costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,
fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed
inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il
novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni
più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello
splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue
spoglie mortali. Il Signorino
(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il
feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha
il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte
a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da
quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di
quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821).
Il Signorino
(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il
feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha
il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte
a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da
quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di
quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821).
 Ma per quale
motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle
attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una
botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente
scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli
obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che
attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi
planimetria).
Ma per quale
motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle
attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una
botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente
scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli
obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che
attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi
planimetria). Al suo
interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma
non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via
degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti.
Al suo
interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma
non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via
degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti. enta gradualmente, facendo
avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.
Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità
del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo
valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si
addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte.
enta gradualmente, facendo
avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.
Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità
del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo
valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si
addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte. un’altezza compresa
fra 170 e
un’altezza compresa
fra 170 e  Queste
tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove
il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo
all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca
rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la
preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha
avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle
condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta
in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte
dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Queste
tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove
il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo
all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca
rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la
preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha
avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle
condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta
in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte
dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano.